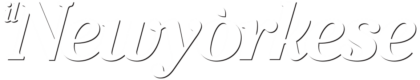Francesca Nonino si presenta subito così: «Sono la sesta generazione della mia famiglia, distillatori in Friuli dal 1897». La voce è appassionata e veloce, un entusiasmo che si capisce subito che non è costruito, e che non smette di crescere via via che si parla.
«Siamo conosciuti nel mondo per aver rivoluzionato il modo di produrre e proporre la grappa», dice. Una rivoluzione che parte da un’idea molto semplice, ma anche molto dirompente: trattare con rispetto la vinaccia, la Materia prima da cui si ottiene la grappa che fino a quel momento veniva considerato un rifiuto.
«La grappa era vista come un prodotto povero, ottenuto dagli scarti.. La chiamavano “acqua di fuoco”, bruciava tutto: anche la fame. I miei nonni, Giannola e Benito Nonino, hanno pensato che selezionando un solo vitigno, invece di distillare le vinacce mescolate insieme, potesse far capire al consumatore che la grappa poteva essere l’anima dell’uva nel bicchiere, l’essenza stessa del vitigno».
È successo nel 1973. Il primo dicembre di quell’anno hanno distillato per la prima volta una grappa monovitigno: da uve di Picolit, un vitigno friulano rarissimo. Da lì, dice Francesca, «È cambiato tutto: si è dimostrato che la grappa poteva essere un distillato fine, complesso, elegante. Oggi tutti fanno grappe monovitigno, ma allora sembrava una follia».
Follia lo sembrava davvero. Quando Giannola Nonino andò dai vignaioli a chiedere di tenere separate le vinacce di Picolit, la risposta fu: «Signora, lei è matta. Noi non ci prenderemo mai il tempo di farlo». E in effetti, a quei tempi non lo faceva nessuno. La vinaccia era uno scarto, punto.
Ma Giannola Nonino non si arrese. «È andata a casa loro, ha parlato con le mogli, e grazie alla cooperazione tra donne è riuscita a ottenere quello che le era stato negato». La rivoluzione della grappa, dice Francesca, è stata una rivoluzione femminile.

Quella storia, lei la conosce da sempre. «Da bambina andavo in distilleria con mio nonno. Non partecipavo, certo, ma osservavo. E soprattutto ascoltavo. E sentivo nella nostra storia dei valori universali, ispirazionali. Capivo che l’amore per il proprio mestiere poteva trasformare il lavorare in una vera e propria missione di vita capace di attrarre e coinvolgere chiunque intorno a te».
Dice che già allora pensava che un giorno le sarebbe piaciuto poter essere parte integrante della storia della sua famiglia «Che un giorno, se avessi avuto figli o nipoti, avrei potuto dire: ho contribuito anche io».
Dopo il Picolit, i Nonino hanno cominciato a distillare anche lo Schioppettino. «E lì hanno scoperto che lo Schioppettino, il Pignolo, il Tazzelenghe erano vitigni diventati illegali. Nell’ingresso nella Comunità Europea non erano stati dichiarati fra le varietà vitivinicole della nostra regione e per questo rischiavano di sparire».
Per salvarli, hanno inventato il Premio Nonino. «All’inizio era un premio in denaro per i vignaioli che mettevano a dimora quelle varietà. Poi, nel 1977, sono riusciti a farle riconoscere e autorizzare». E da lì il premio è diventato un’istituzione culturale, che negli anni ha anticipato sei premi Nobel. «Tutto questo – dice ridendo – con l’obiettivo di fare la grappa più buona del mondo».
Quando le chiedo che ruolo ha oggi in azienda, dice che si occupa di comunicazione digitale: social, sito, e del mercato americano insieme a sua zia Elisabetta. E lo fa con un approccio che non ha niente di museale.
«Non esistono prodotti vecchi, solo narrazioni noiose», dice. «La mia generazione non conosceva la grappa, ma non perché fosse un prodotto sbagliato. Semplicemente, nessuno gliela raccontava nel modo giusto». Secondo lei, molte aziende hanno continuato a comunicare dall’alto, quando invece è necessario parlare in modo diretto al consumatore e renderlo il vero protagonista dell’esperienza con il brand. «Bisogna coinvolgere. E farlo in pochi secondi. Devi essere chiaro, efficace e anche divertente».
Francesca dice che il consumatore moderno è molto più preparato. «Vuole sapere cosa beve, da dove viene, come è stato fatto. Se riesci a raccontarlo nella chiave giusta, lo conquisti».

Nel frattempo, anche la grappa ha cominciato a muoversi. Soprattutto all’estero. «In Italia la grappa si beve liscia, come digestivo. All’estero, invece, si usa anche nei cocktail. E funziona. Dal 2007, grazie a mia zia Antonella, abbiamo fatto innamorare sempre più bartender della grappa in miscelazione».
Negli Stati Uniti, dice, succede il contrario rispetto all’Italia. «Lì si inizia a conoscere la grappa miscelata, nei cocktail. E poi si passa ad assaggiarla in purezza. È un percorso opposto, ma molto efficace». Ci sono bartender, racconta, che hanno fatto della grappa il punto di partenza per sperimentare nuovi mix. «È come se ogni cocktail diventasse la narrazione di due storie: quella del bartender e quella del distillato».
Nei prossimi giorni Francesca partirà per un lungo viaggio negli Stati Uniti. Starà due mesi, con base a New York ma in continuo movimento. «Il primo mese è già pieno: San Francisco, Boston, Detroit, Columbus, Cleveland, Philadelphia… poi si vedrà. Sicuramente anche Miami».
Dice che lavora sul mercato americano da otto anni. «E che negli ultimi quattro o cinque ho capito davvero quanto faccia la differenza. Non abbiamo i budget delle multinazionali. Non possiamo pagare per essere nei menù. Il nostro investimento è viaggiare, incontrare, raccontare».
E funziona. «Quando parli con passione, quella arriva. È un linguaggio universale. Mi è capitato di tornare in locali cinque anni dopo, e trovare ancora persone che si ricordavano di me, che avevano scelto i nostri prodotti. È una questione di connessione umana. Di passioni condivise».
L’ultima volta, racconta, ha partecipato a una cena in un ristorante giapponese dove avevano marinato il salmone nella grappa di Merlot. «Una cosa che non mi sarei mai aspettata. Ed è bellissimo vedere la grappa trovare nuove interpretazioni, anche lontanissime da casa».
Alla fine, le chiedo quale sia, secondo lei, la strategia migliore per valorizzare un prodotto così tradizionale in una città come New York.
Ci pensa un attimo, poi dice: «Ho letto una frase che mi è rimasta impressa: devi prima far innamorare le persone di te, e poi del tuo prodotto».
«Secondo me – continua – serve un prodotto eccellente, certo. Ma anche la voglia di mettersi in gioco, di condividere passione. In una città come New York sei uno tra centomila. La concorrenza è enorme. Se non hai budget pubblicitari, devi costruire relazioni vere. Quelle che nascono da un’affinità reale, da valori condivisi».
«Magari non sarai dappertutto», dice ridendo. «Ma costruirai rapporti che durano nel tempo. Naturalmente si spera per sempre, per adesso posso dirvi che durano almeno da otto anni».