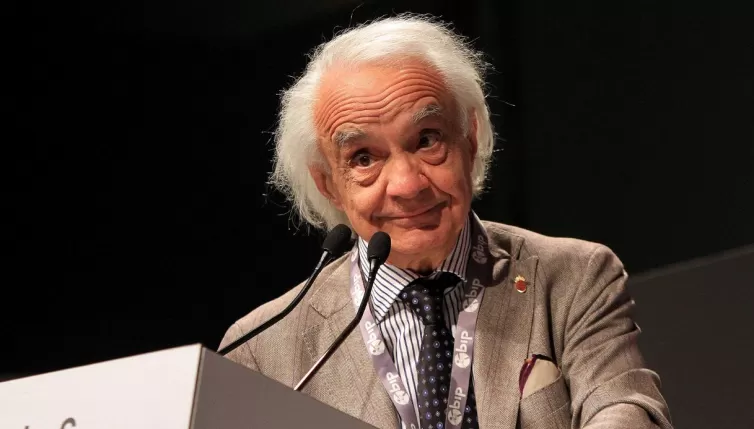Sìnwar, ex capo ormai di Hamas, era sicuramente un terrorista sanguinario, la mente dell’eccidio del 7 ottobre in Israele e il committente – ma anche l’esecutore – di tanti altri omicidi. Per la sua morte ha esultato ieri ovviamente Netanyahu, ma hanno esultato un po’ tutti nel mondo occidentale, in primis il Presidente americano Biden. Eppure, la morte di un uomo, anche se un uomo terribile, quasi in diretta, è sempre conturbante.
Le immagini del drone che lo riprende ferito accasciato su una sorta di poltrona e che lancia un inutile bastone contro quell’occhio invasivo pochi attimi prima del bombardamento fatale, sono fortissime. La fine imminente della vita, di chiunque sia, suscita sempre una sorta di pietas. Almeno in me, che credo di condividere con altri alcune categorie – Kant le definirebbe trascendentali, Freud dell’inconscio, Jung dell’ inconscio collettivo, Sant’Agostino dell’anima, per gli antropologi inglesi mind structures; insomma, quel quid che ci rende essere umani.
La mia non è una riflessione politica e neanche di giustizia, locale o internazionale. Non è neanche la solita riflessione morale sulle tecnologie della rappresentazione visiera che ormai ci fanno vedere tutto in diretta, la pornografia perenne del vigente, secondo alcuni. La morte di un uomo, , giusta per tante ragioni, rimane però sempre, quando la si percepisce negli istanti del trapasso, un grande mistero: il più grande mistero esistenziale che ci sia.