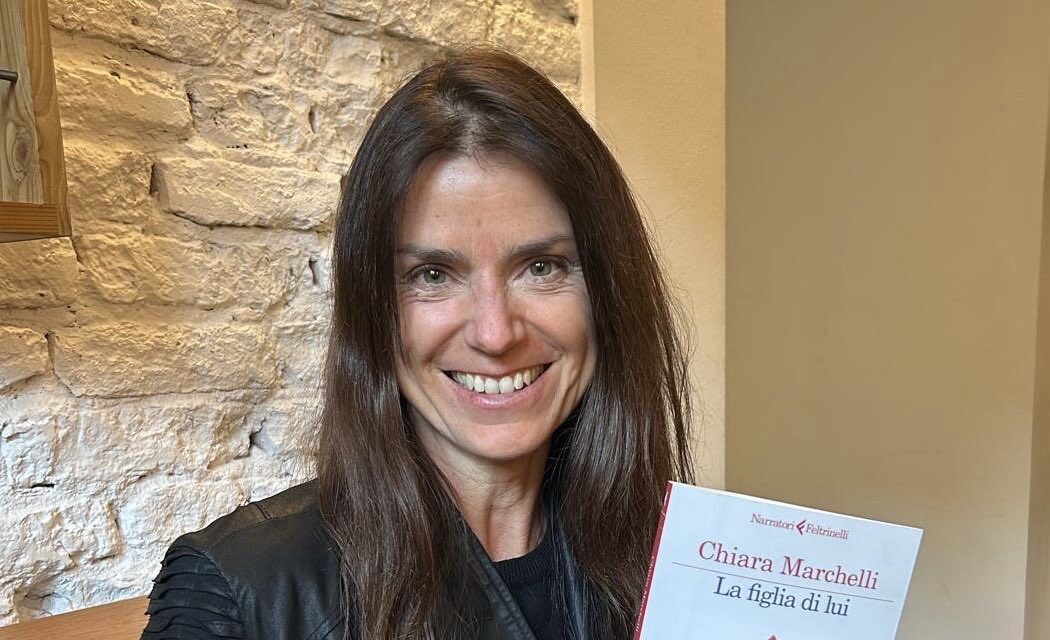Nel racconto dell’avvocato Alessandro Mignacca, la cittadinanza italiana non è solo una questione di leggi, ma anche un riflesso dei grandi cambiamenti storici. Le norme, spiega, devono adattarsi a un mondo che si trasforma, e a una comunità italiana che da secoli vive e si sviluppa ben oltre i confini geografici della penisola. «Con la globalizzazione muta anche la legge o l’interpretazione della norma», dice. E aggiunge: «Scopriremo nei prossimi anni quali saranno le evoluzioni normative, se ce ne saranno».
Una delle trasformazioni più significative è arrivata nel 1992, quando una nuova legge ha permesso agli italiani di acquisire altre cittadinanze senza perdere quella d’origine. Un cambiamento che ha segnato una discontinuità rispetto al passato, quando la naturalizzazione in un altro Paese comportava la perdita automatica della cittadinanza italiana. «Precedentemente alla normativa del 1912 era in vigore quella del 1865 che, per certi versi, era più stringente», ricorda Mignacca. Oggi invece, è possibile avere anche tre cittadinanze contemporaneamente.
Ma il diritto, per quanto scritto, viene anche interpretato. E a volte queste interpretazioni cambiano improvvisamente, creando incertezza. È il caso della recente circolare del Ministero del 3 ottobre 2024, che ha stabilito che la naturalizzazione di un genitore, prima del 1992, comportava anche la perdita automatica della cittadinanza italiana per i figli minorenni. «Restando salvo ora solo figlio già maggiorenne», spiega Mignacca, «maggiore età che si raggiungeva al compimento del 21simo fino al 1973, oggi invece al compimento del 18simo anno».
Questa nuova lettura mette a rischio il diritto di molte persone, soprattutto nella comunità italoamericana. Ma l’avvocato è fiducioso: «Confidiamo di poter far cambiare nuovamente interpretazione al Ministero, anche attraverso delle conquiste giudiziali», dice. È un terreno, quello del diritto alla cittadinanza, in cui spesso la giurisprudenza ha anticipato o corretto le scelte politiche. Come nel 2009, quando la Corte di Cassazione ha aperto la possibilità di ottenere la cittadinanza anche ai discendenti delle donne italiane, nate prima del 1948.
Mignacca guarda con attenzione anche alle dinamiche sociali e culturali che accompagnano questi cambiamenti. L’Italia è un paese di emigrazione, e la sua popolazione è dispersa in tutto il mondo. «Ad ogni modo questa migrazione massiva ha fatto in modo che poi l’Italia si riconoscesse con questi luoghi», osserva. Un riconoscimento che è andato ben oltre l’ambito burocratico: le comunità italiane all’estero sono diventate spesso le custodi di una certa idea di italianità.
Il tema coinvolge anche una riflessione più ampia sul rapporto tra cittadini e istituzioni. «Molti italoamericani si trovano a non avere più diritto alla cittadinanza a seguito di questa nuova interpretazione», afferma Mignacca. Sono situazioni complesse, in cui spesso la legge sembra ignorare la continuità familiare, la cultura trasmessa e il senso di appartenenza. Il diritto è chiamato a fare i conti con queste contraddizioni.
Nonostante le difficoltà, l’obiettivo dello studio legale guidato da Mignacca è chiaro: accompagnare le persone in questi percorsi e far valere i loro diritti. Lo fa anche per contribuire, in modo concreto, a una visione più moderna della cittadinanza. «Noi siamo vicini alla realtà delle Americhe», conclude, «ma per ora restiamo in Italia». Il progetto, però, guarda lontano. E segue da vicino ogni mutamento, non solo della legge, ma della società che la legge dovrebbe rappresentare.