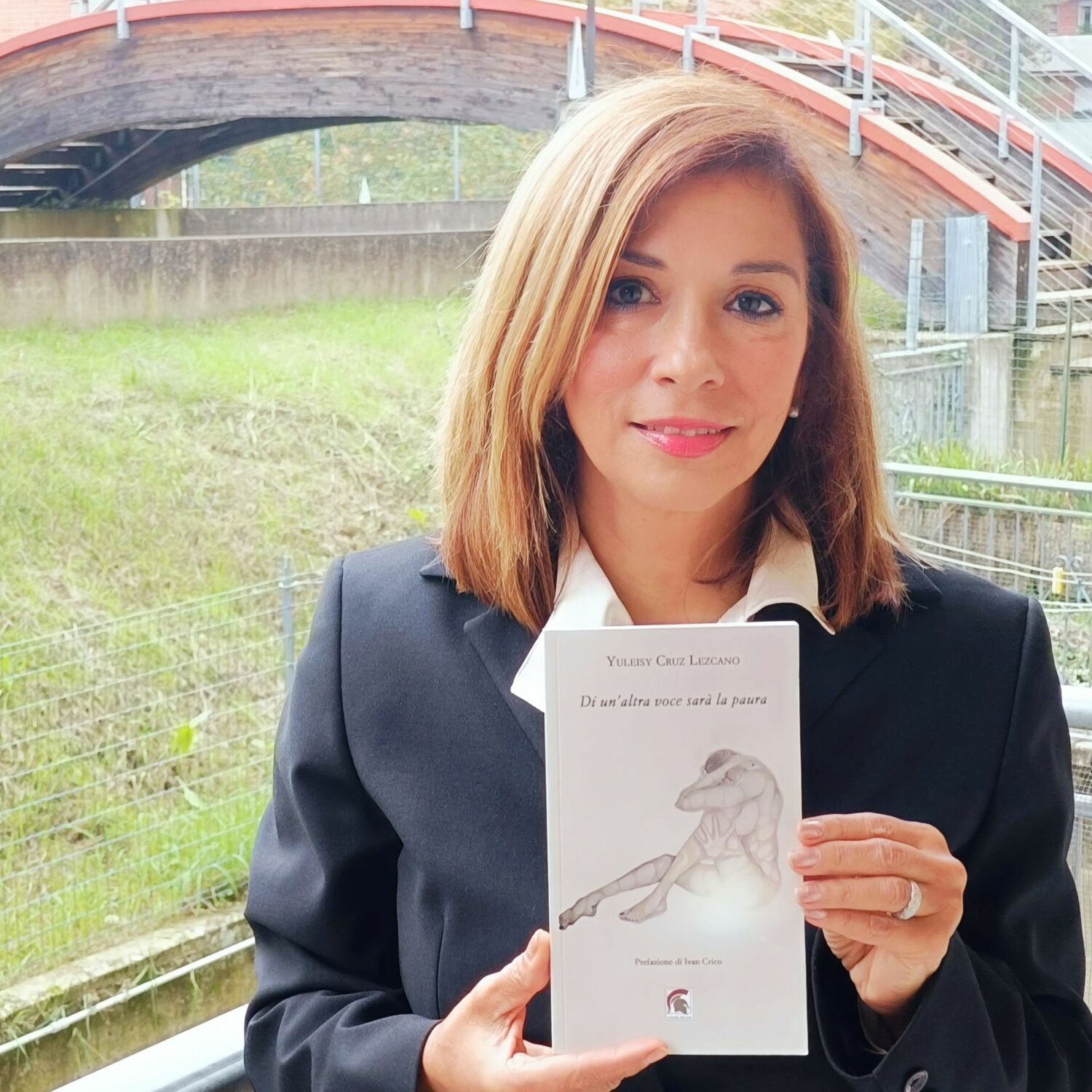In Italia la proposta di legge che riscrive articolo 609‑bis del codice penale, introducendo il principio del “consenso libero e attuale” come base del reato di violenza sessuale, è stata approvata all’unanimità dalla Camera dei Deputati nel novembre 2025. La norma avrebbe segnato un cambiamento epocale: non più la coercizione, la minaccia o la forza come condizioni necessarie, ma l’assenza di un sì chiaro, libero e presente. Tuttavia, a pochi giorni da quella storica approvazione, il Senato della Repubblica ha deciso di rinviare il voto, spostando la discussione a febbraio 2026. Con il rinvio, la legge, pur già pronta, resta sospesa: il consenso atteso rimane sulla carta, mentre nella vita quotidiana le vittime continuano ad affrontare un sistema che grava su chi ha subito violenza, chiedendole di provare la resistenza, la minaccia, la costrizione. Perché, in un Paese che si dice pronto al cambiamento, questo iter legislativo si arresta? La risposta non sta solo nella contesa politica, ma in una struttura culturale radicata, fatta di stereotipi, di modelli patriarcali, di minimizzazioni della violenza, che da decenni viene denunciata da organismi internazionali.
La difficoltà di approvare definitivamente una legge sul consenso non è un fatto tecnico: è la manifestazione di un rifiuto sociale a riconoscere la libertà sessuale come un diritto autonomo, non subordinato alle prove della violenza fisica o alla resistenza. In molte parti del nostro Paese ancora pesa l’idea che il corpo di una donna o di una persona vulnerabile, sia in qualche modo “disponibile”, o che il silenzio significhi assenso, o che la mancanza di rifiuto equivalga a accettazione. Un fattore aggravante è che in Italia non esiste ancora un sistema diffuso e obbligatorio di educazione alla sessualità, al consenso, all’affettività nelle scuole: l’istruzione sessuale rimane perlopiù volontaria e frammentaria, gestita in modo disomogeneo da scuole e regioni. Questo vuoto educativo lascia terreno fertile a stereotipi, disinformazione, e alla negazione del valore del “sì” come libera manifestazione di volontà. La riforma del 609‑bis sarebbe stata non solo un aggiornamento giuridico, ma una leva di trasformazione culturale: rendere la legge specchio della dignità e dell’autodeterminazione, non interpretazione soggettiva della resistenza. E invece, con il rinvio, restiamo in un limbo: la legge c’è in prima lettura, ma non basta. Il consenso, nella prassi sociale e giudiziaria, resta incerto.
Nel contesto italiano, segnato da patriarcato strutturale, disparità di genere, mentalità di possesso e controllo, solo con la legge non basta: servono investimenti nella formazione, nella prevenzione, nell’educazione al rispetto, fin dalla scuola. Occorre un cambiamento profondo, che attraversi le istituzioni tanto quanto le relazioni private, perché la giustizia non si misura solo in codici, ma nel modo in cui trattiamo l’altro, nella responsabilità collettiva di riconoscere la libertà come valore inviolabile.
Il rinvio al Senato rappresenta quindi non solo un ostacolo normativo, ma un segnale: la cultura del consenso, quella che rispetta l’autodeterminazione e la dignità, non può ridursi a materia di diritto penale, ma deve diventare parte dell’identità di una società che vuole dirsi civile. La riforma resta incompiuta: il consenso atteso resta sospeso, e con esso, la speranza che la legge diventi davvero strumento di cambiamento, prima ancora che di punizione.
L’introduzione del principio del “consenso libero e attuale” nella riforma dell’articolo 609‑bis era vista come un allineamento dell’Italia agli standard internazionali in materia di diritti umani e di tutela delle donne. La proposta, approvata all’unanimità alla Camera dei Deputati il 19 novembre 2025, prevedeva che qualunque atto sessuale senza un consenso esplicitamente e liberamente manifestato fosse configurabile come violenza sessuale, con pene da sei a dodici anni di reclusione. Il testo recepisce le indicazioni della Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013, che impone agli Stati di garantire protezione contro tutte le forme di violenza di genere, incluse quelle sessuali basate sulla mancanza di consenso. Eppure, nonostante il consenso unanime in prima lettura, la legge non ha ottenuto l’approvazione definitiva: il 25 novembre 2025, nel giorno in cui si celebrava la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il voto al Senato è stato rinviato a febbraio 2026. Decisione motivata con la richiesta di “ulteriori approfondimenti”, ma che per molte associazioni e operatori rappresenta un segnale grave: un rinvio che lascia le vittime senza uno strumento reale di tutela.
Per comprendere perché questa battuta d’arresto appare così paradossale, bisogna guardare alla radice: in Italia la violenza contro le donne, e la sua accettazione sociale, è ancora profondamente intrecciata con stereotipi patriarcali, con forme di controllo sul corpo e sulla libertà femminile, e con una cultura che spesso considera il silenzio o la mancanza di rifiuto come consenso. Un paradigma che rende difficile la trasformazione normativa se non si affianca a un lavoro culturale di lunga durata.
La stessa Convenzione di Istanbul, e la CEDAW (Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne), da decenni richiamano l’Italia al compito di intervenire non solo sul piano penale, ma su quello educativo e sociale: affinché la parità di genere, il rispetto della dignità, la libertà di autodeterminazione siano parte integrante dell’ordinamento, della scuola, delle istituzioni.
Un esempio concreto di quanto la normativa non basti: le statistiche nazionali mostrano che il femminicidio, e la violenza di genere in genere, non diminuiscono. Nonostante l’inasprimento delle pene negli ultimi decenni, gli omicidi di donne restano una ferita aperta, spesso dentro le mura domestiche o nelle relazioni di potere. Ciò dimostra che la punizione arriva sempre dopo, a violenza già consumata; non previene, non trasforma la mentalità, non modifica i rapporti sociali. Per questo è urgente accompagnare la riforma a misure strutturali: educazione alla sessualità e al rispetto del consenso nelle scuole, percorsi di sensibilizzazione, sostegno ai centri antiviolenza, formazione di magistrati e forze dell’ordine, sostegno economico e sociale per le vittime.