Ogni 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le piazze si riempiono e le istituzioni rilanciano impegni e promesse. Ma senza definizioni univoche e dati chiari, la violenza di genere rimane un fenomeno frammentato, facilmente negabile. Da questo vuoto culturale, istituzionale e politico muove il libro di Donata Columbro, Perché contare i femminicidi è un atto politico (2025).
Giornalista, scrittrice, nonché “data humanizer” per il suo modo accessibile e inclusivo di divulgare questioni di statistica e data science, Columbro prende in esame il modo in cui in Italia vengono registrati ufficialmente i femminicidi, risalendo alle radici di una percezione spesso minimizzata della violenza di genere. Confrontandosi con esperienze internazionali di “femminismo dei dati” — una prospettiva utilizza la raccolta e l’analisi dei numeri come uno strumento di giustizia sociale e attivismo politico — l’autrice mostra come dietro al conteggio dei femminicidi si celi in realtà una questione di potere, responsabilità e resistenza.
Il cuore della sua analisi è racchiuso in una premessa che smonta l’illusione della neutralità statistica: «I dati non sono mai neutri. Sono il risultato di scelte, di priorità, di potere».
Contare i femminicidi, significa scegliere di vedere e, di conseguenza, scegliere di agire. In Italia, non esiste una banca dati pubblica e regolarmente aggiornata. Le fonti istituzionali sono parziali e insufficienti a monitorare il fenomeno, come nel caso del rapporto trimestrale sugli omicidi volontari (in cui si annovera anche una distinzione per genere e relazione vittima-autore) fornito dal Ministero dell’Interno, o dei dati dell’ISTAT, più precisi, ma pubblicati con cadenza annuale.
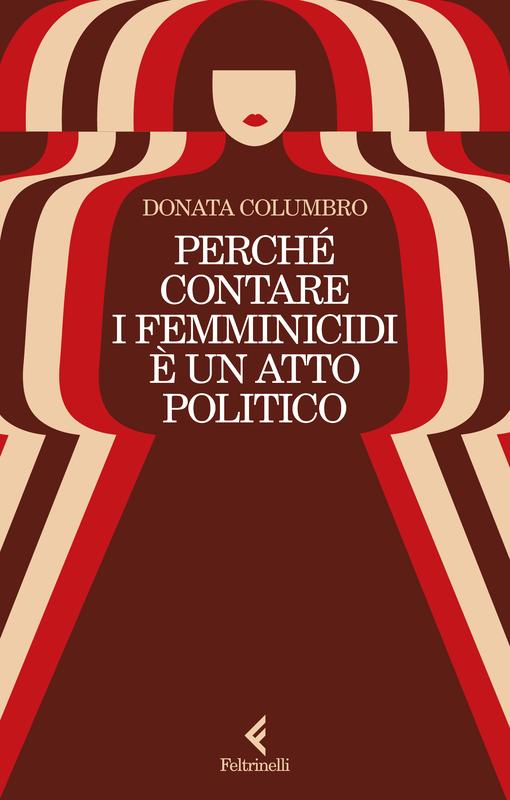
«Quello che non si conta, non esiste nelle politiche pubbliche», sostiene l’autrice. L’assenza di un registro ufficiale spiegherebbe quindi la difficoltà nel riconoscimento della violenza di genere come un problema strutturale e nella realizzazione di politiche efficaci. Si comprende così l’importanza attribuita all’enorme lavoro di raccolta e monitoraggio dal basso di dati condotto da associazioni, centri antiviolenza, attiviste e giornaliste femministe, come mostra l’esperienza dell’Osservatorio di Non una di meno in Italia, o iniziative analoghe in Brasile, Argentina e Messico.
Columbro muove dalla definizione stessa di femminicidio e dal suo utilizzo che si è andato diffondendo, per rivolgersi poi alla disamina dei criteri con cui viene contato e raccontato. Se è vero che i numeri hanno contribuito a dare forma e dimensione al fenomeno, rendendolo riconoscibile come punta dell’iceberg di una violenza sistemica. Allo stesso tempo, essi raccontano molto anche del contesto che li produce: un sistema di stereotipi e pregiudizi in cui la violenza patriarcale resta spesso invisibile. I dati (non solo quelli sui femminicidi) non sono oggettivi, ma sono prodotti sociali, raccolti e selezionati per determinate finalità. Per questo anche decidere quali dati citare è una scelta politica: significa decidere di rappresentare un determinato pezzo di realtà.
Una volta dimostrato che l’oggettività è un mito e ciò che conta è la metodologia, la trasparenza, la consapevolezza della propria prospettiva; ritornando al caso della violenza di genere, i “controdati” hanno metodologie e obiettivi diversi da quelli istituzionali: esplicitano il punto di vista, colmano lacune, contestano narrazioni minimizzanti. Pertanto, come afferma l’autrice in un’intervista per illibraio.it: «Non dobbiamo limitarci a chiederci se i dati siano ‘oggettivi’, ma domandarci piuttosto che cosa ci dicono, quale vuoto colmano […]».
C’è una labile soglia tra numeri e parole, a dispetto della convinzione granitica di cui si alimenta la nostra società. La scissione tra scienze e lettere, e la conseguente frammentazione e specializzazione dei saperi, ha infatti un’origine relativamente recente, che va di pari passo con l’affermarsi della cultura moderna. Di questa prossimità semantica testimonia lo stesso termine “raccontare”, tra le cui ipotesi etimologiche più accreditate c’è quella che risale al latino “con” e “putare”, ovvero “calcolare” o “verificare un conto” preceduto dal prefisso rafforzativo. In questo senso, “raccontare” significa abbozzare un discorso a partire da “conti” — da intendersi qui nella doppia accezione di numeri e parole. Sebbene l’analisi di Columbro proceda per sentieri più concreti e storici, è questo l’assunto implicito al cuore del libro, quando insiste sulla dimensione umana dei numeri. «Contare non significa ridurre a numero — scrive — significa riconoscere, ricordare, restituire dignità». Per questo molte associazioni e progetti dal basso, come l’Osservatorio Femminicidi Lesbicidi Transcidi di Non Una di Meno, raccolgono informazioni più complete dello Stato: nominano le vittime, ricostruiscono le storie, contestano una narrazione che tende a minimizzare. Le esperienze di femminismo dei dati riportate contano e raccontano: non solo definiscono parole e fenomeni attraverso i numeri, ma trasformano i numeri stessi e le storie in strumenti di orientamento, in memoria collettiva, in richiesta politica.
Il libro insiste così sulla dimensione politica del contare. «Chi decide cosa contare – ribadisce Columbro – decide cosa è importante». E dove i dati sono accurati e pubblici, come in Spagna o in alcuni paesi dell’America Latina, il dibattito è più solido, le politiche più efficaci, la prevenzione meno spettacolare e più concreta. Contare i femminicidi diventa allora un atto politico non solo perché racconta una realtà diversa, in cui la violenza di genere è un male strutturale della società patriarcale; ma anche perché costringe le istituzioni a misurarsi con l’evidenza, a rendere conto dei vuoti, a investire. Ci permette di percepire meglio il fenomeno, colma il vuoto culturale, nonché il divario tra conoscenza e azione. E la liberazione dalla violenza passa necessariamente da qui.



