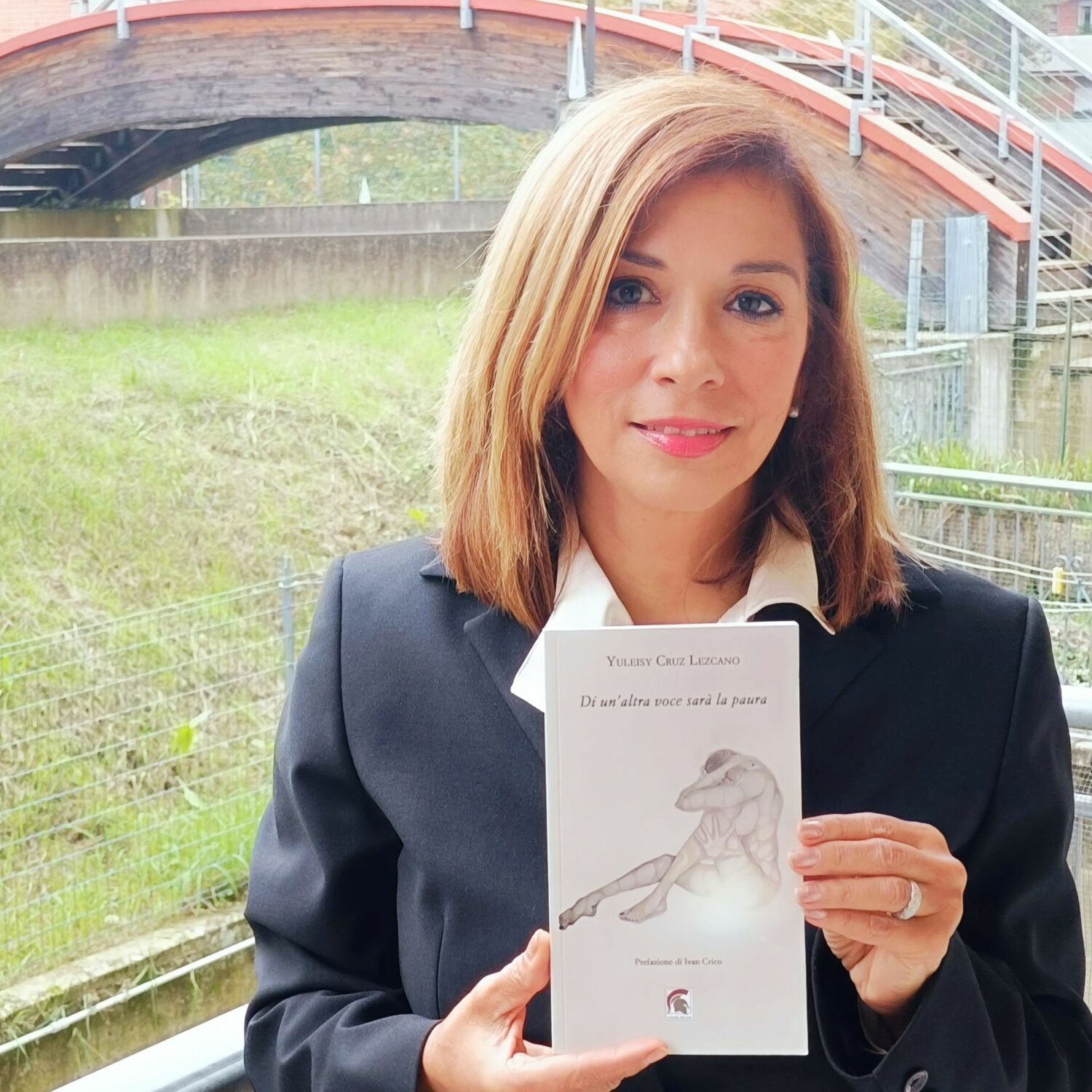Facciamo ancora in tempo per riconquistare i nostri desideri? O siamo stati ormai definitivamente condannati a essere tele-diretti da interessi estranei alla nostra volontà, sospinti da logiche di consumo, algoritmi, e meccanismi invisibili che decidono per noi cosa vogliamo, chi siamo, cosa dovremmo diventare? È una domanda urgente, non solo filosofica ma profondamente esistenziale, che ci riguarda ogni giorno, ogni volta che scegliamo – o crediamo di scegliere – tra un prodotto, un’idea, uno stile di vita. Siamo davvero liberi quando desideriamo? O stiamo solo rispondendo a una chiamata esterna, confezionata apposta per noi?
Il desiderio ha origini complesse, sia coscienti che inconsce. A volte nasce da un bisogno reale, altre volte da un vuoto simbolico. Ma nel tempo presente, questo mistero originario viene colonizzato, analizzato, sfruttato. Tutto ciò che può essere desiderato può essere venduto. E tutto ciò che si vende deve prima essere desiderato. È così che funziona il capitalismo emozionale, che prima risveglia desideri immediati – fame di status, di attenzione, di riconoscimento – e poi li offre già pronti, impacchettati, monetizzati. È la logica del “click”, della “call to action”: se non desideri, non consumi. Se non consumi, non esisti. Per fortuna, non tutti si arrendono a questa visione distorta. Esiste una corrente etica e filosofica del desiderio, un tentativo di restituire senso e dignità a questa forza primordiale dell’essere umano. Lo studioso spagnolo Manuel Cruz Ortiz, per esempio, parla della necessità di una “civilizzazione del desiderio”, cioè un processo culturale e politico per ricondurre il desiderio verso una forma umana, vissuta, consapevole. In questa prospettiva, non si tratta di reprimere il desiderio – come spesso ha fatto una certa morale antica – ma di dargli la forma adeguata, di riordinarlo, comprenderlo, educarlo. Desiderare è naturale, ma non tutto ciò che desideriamo ci rende felici, e non tutto ciò che ci fa piacere ci fa bene.
Una delle grandi omissioni della nostra epoca è il silenzio educativo sul desiderio. A scuola si parla di matematica, storia, grammatica, perfino di cittadinanza. Ma chi insegna ai ragazzi a capire cosa desiderano? Chi li aiuta a distinguere un desiderio autentico da uno indotto? Dove si insegna a riflettere sulla dinamica del desiderare, sulle sue motivazioni profonde, sulle sue trappole e sulle sue possibilità? Non si parla dei piaceri, né della loro priorità. Non si insegna a godere della vita in modo libero, ma solo a perseguire risultati, obiettivi, performance. Così cresciamo insoddisfatti, perché viviamo una molteplicità di opzioni di consumo, ma senza bussola, senza profondità, senza direzione. Un paradiso apparente, che spesso nasconde un vuoto esistenziale.
Per questo, più che reprimere i desideri, serve giocare con loro, danzare con le nostre pulsioni senza esserne schiavi. Serve una strategia che non elimini il desiderio, ma che lo renda alleato della vita, non nemico. Desiderare non è un male, ma è necessario imparare a desiderare bene, con misura, con coscienza, con gioia. Una civiltà del desiderio dovrebbe insegnare proprio questo: il piacere di desiderare, il piacere di attendere, il piacere di costruire. Una cultura vissuta, che metta al centro le priorità dei desideri, non il loro accumulo. Una cultura che ci permetta di capire se siamo qualcosa di più della nostra stessa volontà, o se, al contrario, siamo interamente determinati da essa.
Nel mondo digitale, tutto si accelera. I social media, le piattaforme, gli algoritmi sequestrano il nostro desiderio per trasformarlo in tempo di permanenza, clic, profilazione. Ogni nostra azione è studiata per generare nuovi stimoli. Ma questa sovraesposizione ha un costo: perdiamo contatto con l’origine del nostro desiderare. Diventiamo reattivi, compulsivi, disconnessi da noi stessi. In questo senso, la riconquista del desiderio è anche una battaglia culturale e spirituale. Riguarda il nostro tempo, la nostra libertà, la nostra capacità di costruire un senso. Perché desiderare non è solo volere: è progettare, creare, dare direzione alla propria vita.
Siamo ancora in tempo, sì. Ma serve un cambiamento radicale. Un’educazione sentimentale, una pratica filosofica, una cultura nuova che ci aiuti a riscoprire la genesi del nostro desiderare e a orientarlo verso ciò che ci realizza davvero.
In fondo, non saremo mai pienamente liberi se non impariamo a conoscere, ordinare e abitare i nostri desideri. Perché chi controlla i desideri, controlla l’anima. Ma chi li conosce, li vive e li guida, può finalmente tornare a essere artefice di sé.