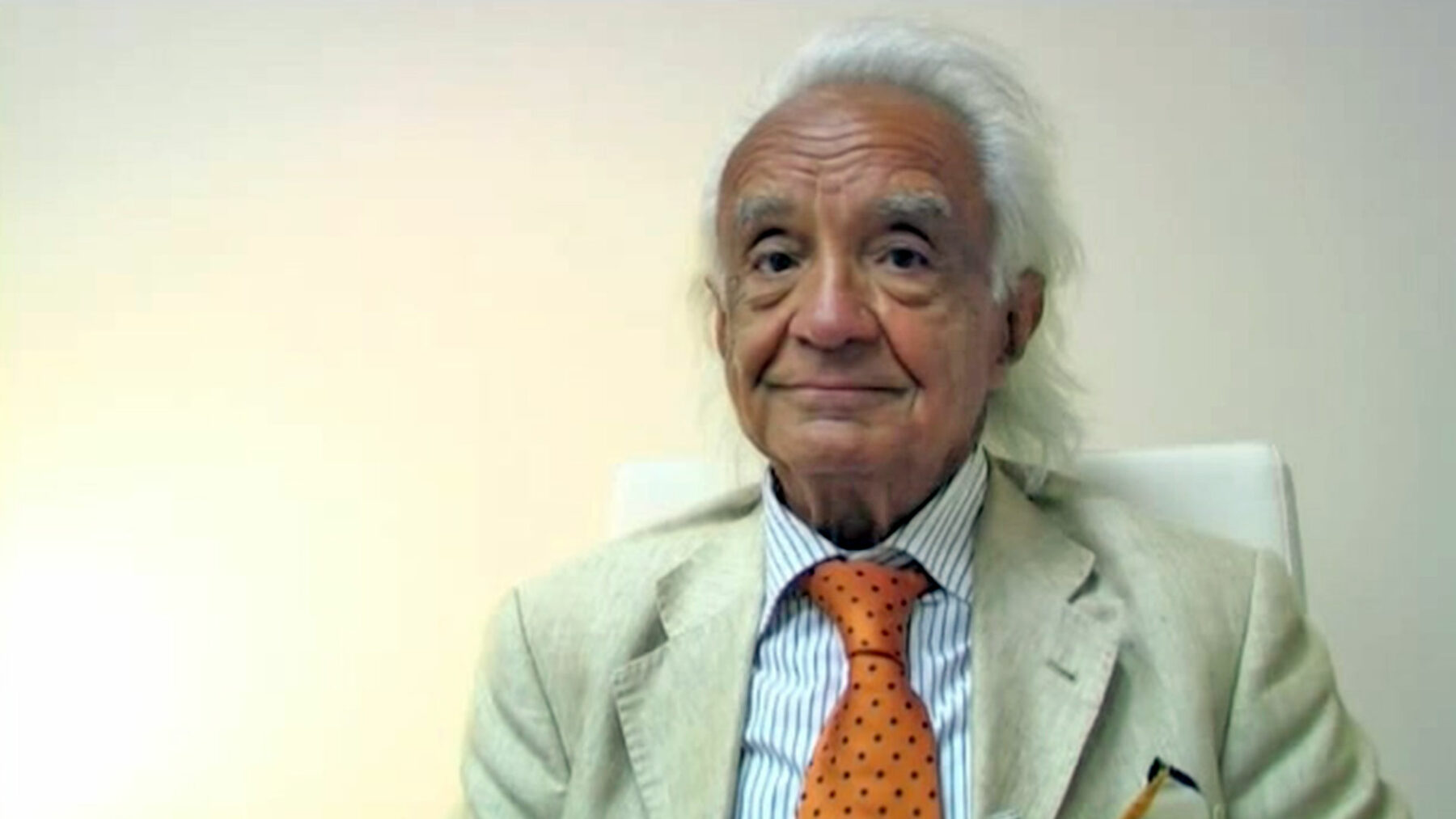Accanto a continui interventi, polemiche giornalistiche e normative sulla Giustizia, il contesto delle carceri minorili italiane rimane ai margini delle discussioni. Eppure negli ultimi dodici anni la criminalità minorile ha avuto un incremento del 15,34%. Per non parlare della microcriminalità, che ormai non viene quasi più denunciata alle forze di Polizia.
Le segnalazioni di minori tra i 14 e i 17 anni, denunciati e arrestati, sono cresciute da 28.196 nel 2010 a 32.522 nel 2022. Nonostante un calo del 14,09% tra il 2015 e il 2019, il 2021 ha visto un lieve rialzo del 3,27% rispetto al 2019. Nel 2022 si è registrato un livello quasi pari a quello del 2013, mostrando la persistenza del fenomeno e evidenziando la necessità di interventi mirati a contrastarlo.
Emergenza o Tendenza
Non si tratta di un’emergenza nel senso tradizionale del termine, qualcosa che affiora improvvisamente in superficie e richiede una risposta immediata e temporanea, concentrata sugli effetti visibili. Piuttosto è una tendenza, un fenomeno continuo che necessita di uno studio delle radici del problema. Se giudicare rapidamente e senza possibilità di cambiamento è un’operazione sterile, capire significa invece restituire un senso al fenomeno, aprendo le porte a percorsi di inclusione e prevenzione. Dall’altro lato è quindi necessario un approccio sistemico e a lungo termine, che coinvolga enti del terzo settore, famiglie, istituzioni e società civile, nel tentativo di invertire la tendenza negativa in atto.
Rivolta o Protesta
Quando i giovani autori di reato sentono di non essere ascoltati, dovrebbero poter reagire al muro del silenzio, nonostante la privazione di libertà. Recentemente, al carcere minorile Beccaria di Milano, alcuni ragazzi detenuti si sono rifiutati di rientrare nelle loro celle, battendo sulle sbarre.
Ci riferiamo a una struttura in cui 21 agenti della Polizia penitenziaria sono stati accusati di maltrattamenti nei confronti dei ragazzi detenuti, violenze che continuavano da almeno due anni. Definire rivolta il battere sulle sbarre delle celle significa non comunicare chiaramente quanto accaduto, cioé una manifestazione di dissenso, rientrata in poche ore. Una protesta che rivela una profonda sfiducia verso lo Stato e un malessere diffuso tra i giovani detenuti, motivato da cattive condizioni di vita in strutture carcerarie sovraffollate e prive di servizi decenti. Rappresentare i fatti come rivolta recide il dialogo con i ragazzi e può condurre a giustificare l’attivazione di leggi dal carattere meramente punitivo, con pene sproporzionate, atte solo a reprimere questi eventi.
Ragazzi colpevoli o adulti responsabili
I minorenni, così influenzabili dalle negatività che li circondano, hanno bisogno di esperire un “mondo adulto sufficientemente buono”, come suggeriva lo psicoanalista Donald Winnicott. Tuttavia, la realtà odierna rivela un crollo di pilastri sociali come la famiglia e la scuola, con crepe significative che compromettono la loro capacità di fornire sostegno e guida ai giovani. Le famiglie si trovano spesso a oscillare tra due estremi: da un lato, l’assenza in cui i bisogni dei ragazzi sono trascurati e le relazioni affettive sono carenti; dall’altro, l’iperpresenza, caratterizzata da un’eccessiva soddisfazione dei bisogni concreti e dall’anticipazione dei desideri dei figli. Questo tipo di dinamica impedisce lo sviluppo di un equilibrio emotivo solido, favorendo una disregolazione emotiva nei giovani, rendendoli vulnerabili e inclini a comportamenti devianti.
Punitivo o riabilitativo
Nel dibattito sulle politiche riguardanti gli interventi per i giovani rei emergono due prospettive di pensiero, tra loro alternative. Da una parte, il modello riabilitativo sostiene che i programmi di intervento debbano fornire gli strumenti necessari per indirizzare questa popolazione verso esiti positivi dopo il contatto con il sistema di giustizia penale. Dall’altra parte, il modello punitivo suggerisce che attraverso l’attuazione di sanzioni più severe per i giovani autori di reato (come la detenzione), vi sia una possibilità più concreta di correggere il loro comportamento e scoraggiare nuovi atti criminali, fornendo loro l’occasione concreta di imparare dalle conseguenze delle proprie azioni. A livello empirico, appare evidente che l’approccio riabilitativo, rispetto a quello punitivo, sia più promettente nel generare un cambiamento positivo. L’ambiente detentivo non risulta la soluzione ottimale per ridurre il comportamento deviante, in quanto mal si concilia con le esigenze di sviluppo giovanile. La detenzione rafforza lo stato di separazione dei soggetti rei rispetto alla società, agevolando la persistenza di comportamenti antisociali.
Questa direzione riabilitativa, allora, non è solo un atto di umanità e un’alternativa che lo Stato deve offrire ai giovani, in osservanza dell’articolo 27 della Costituzione che sancisce che la pena debba “tendere alla rieducazione del condannato”; ma rappresenta anche un motivo di sicurezza pubblica e di tutela a lungo termine della nostra società civile. Come sostiene Francesca Fagnani “È un bene per tutti se un ragazzo che entra in un istituto penitenziario da spacciatore, rapinatore o altro, una volta uscito, cambi mestiere”.
Qui si evidenzia la complessità del tema: non è agevole elaborare soluzioni univoche quando la questione è così articolata da subire diverse interpretazioni e quindi [P1] diverse azioni da mettere in campo.
Anzitutto, è prioritario ascoltare gli esperti che si dedicano da anni alla cura e alla giustizia dei minori. Queste persone, spesso trascurate nonostante la loro esperienza diretta, offrono una prospettiva matura e informata. Inoltre mettono al centro il minore, cosa che non sempre la legge -come il decreto Caivano- e neppure le famiglie fanno.
Il punto chiave è forse un altro: per affrontare tematiche così complesse, la soluzione non può derivare da un singolo ente o da un singolo programma, ma richiede la collaborazione sinergica di diversi attori con competenze diverse. Si tratta di attivare un percorso di inclusione sociale multidisciplinare, sfruttando le competenze complementari di vari attori (organizzazioni non-profit, enti accreditati al lavoro e alla formazione, comunità, USSM, ATS …) orientati verso l’obiettivo comune di permettere a ciascun ragazzo il distacco dalla personalità deviante, creando una nuova immagine di sé e una prospettiva per il futuro. La via maestra si trova attraverso la possibilità di costruirsi parole e azioni nuove, uscendo dalla dittatura delle youth gang con un ascolto indiretto di parole e idee (una didattica come in Socrate) in ambienti utili a formare una consapevolezza del sé, un dialogo interiore che i minorenni non hanno avuto modo di costruire e definire, utile a valutare le conseguenze dei reati e il valore di un comportamento non trasgressivo.
Per i profili di fragilità sociale è quindi essenziale un duplice obiettivo a lungo termine: non solo allontanarsi dal circuito criminale, ma anche costruire un’identità prosociale del ragazzo.
L’ambiente familiare si configura come uno degli aspetti più importanti da affrontare nei percorsi di inclusione, ottenendo risultati efficaci nel contenere il rischio di recidiva e nell’aumentare il potenziale riabilitativo degli interventi per il giovane autore di reato. La famiglia rappresenta il terreno primario dove si apprendono valori, norme e comportamenti per il giovane. Tuttavia, quando il modello familiare è compromesso da dinamiche negative o devianti, diventa un fattore di rischio significativo per lo sviluppo antisociale. Per questo, ricostruire e rafforzare un contesto familiare positivo è un elemento cardine nel reinserimento, che richiede interventi mirati su due fronti: interventi, col coinvolgimento del minore e della sua famiglia, ma anche con interventi solo sulla famiglia. I primi favoriscono la ricostruzione dei legami familiari e promuovono una prospettiva che riconfiguri il reato come manifestazione di dinamiche più profonde, evitando atteggiamenti deresponsabilizzanti o eccessivamente colpevolizzanti. I secondi sono focalizzati sul fatto che, parallelamente all’evoluzione del percorso di cambiamento del ragazzo, vi è necessità che la famiglia si adatti a tali mutamenti. La capacità di accogliere il minore richiede adeguamenti nelle dinamiche familiari e l’instaurarsi di nuovi e più efficaci equilibri. Il successo di questo approccio dipende dalla formazione di coloro che operano nell’ambito e soprattutto dalla collaborazione delle famiglie coinvolte, cosa che influisce direttamente sulla riuscita dei programmi di reintegrazione e sulla capacità del giovane di evitare la ripetizione di reati.
I minori presentano multi-esigenze, che riguardano sia la sfera della salute fisica, che quella della salute mentale. Ripristinare un buono stato psicofisico è condizione essenziale per accedere a opportunità future, come quelle lavorative, educative e abitative. Gli interventi focalizzati sulla gestione delle dipendenze rivestono un ruolo rilevante, affrontando le problematiche in entrambe le aree. Per quanto riguarda la salute mentale, l’approccio specialistico come la terapia cognitivo-comportamentale si dimostra efficace nel fornire strumenti immediati per ridurre i fattori di rischio che potrebbero predisporre a comportamenti criminali.
Infine, l’istruzione e la formazione giocano un ruolo fondamentale nella reintegrazione del ragazzo: non solo forniscono competenze utili per il mondo del lavoro, ma contribuiscono anche a ridurre il senso di isolamento e a potenziare l’autostima, tutti fattori che convergono nella costruzione di un senso di sé prosociale.
Fonti
Chitsabesan, P., & Bailey, S. (2006). Mental health, educational and social needs of young offenders in custody and in the community. Current Opinion in Psychiatry, 19(4), 355-360.
Pappas, L. N., & Dent, A. L. (2023). The 40-year debate: a meta-review on what works for juvenile offenders. Journal of Experimental Criminology, 19(1), 1-30
Polizia di Stato. (2023). Criminalità minorile in Italia 2010-2022. Dipartimento della Pubblica Sicurezza. https://www.poliziadistato.it/statics/10/criminalita-minorile-in-italia-2010-2022.pdf
Tarolla, S. M., Wagner, E. F., Rabinowitz, J., & Tubman, J. G. (2002). Understanding and treating juvenile offenders: A review of current knowledge and future directions. Aggression and violent behavior, 7(2), 125-143
Van Dooren, K., Richards, A., Lennox, N., & Kinner, S. A. (2013). Complex health-related needs among young, soon-to-be-released prisoners. Health and Justice, 1, 1.