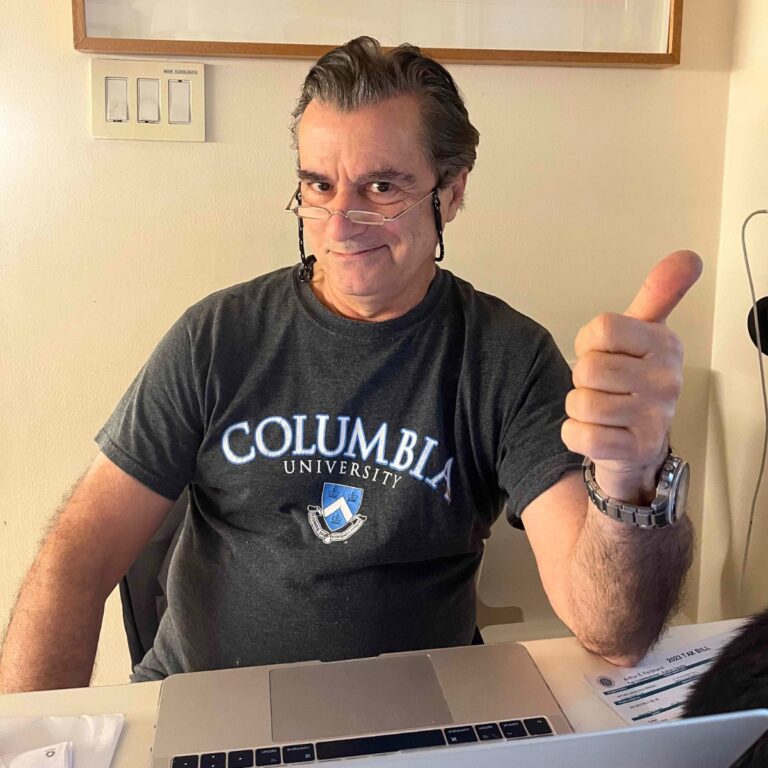La mia passione per il caffè è indiscutibile, fin dal tempo in cui mia nonna Anîta, a insaputa di mia madre, ne faceva scivolare un tantino nella tazza del mio latte mattutino. Dava a quel latte un aroma intrigante. Oggi non ne sono dipendente come certi italiani, ma non passa giorno senza un paio di buone tazze. Al mattino mi è indispensabile, per poter connettere e capire chi sono, che anno è, e dove caspita mi trovo. Non so bene come riesco a dirigermi verso la macchina del caffè. Il primo è immancabilmente un espresso, un cappuccino di domenica, ma vi confesso che le mie sinapsi non connettono bene prima della seconda tazza. Atterrare da italiano negli Stati Uniti, ha corroborato l’indelebile italianità in me. Credo infatti che il caffè definisca meglio di qualunque altro costume la poliedricità della cultura americana, distinguendola nettamente da quella italiana, dove il caffè è il risultato di una secolare ricerca “di astrazione” tendente alla perfezione assoluta, forse più di qualunque altra forma d’arte culinaria. Questa storia inizia dal mio arrivo a Boston, dove il caffè americano regnava incontrastato e dove, per bere un espresso, a volte persino per trovare una macchina da bar, dovevo andare al quartiere italiano.
Durante la mia pluridecennale residenza negli USA mi sono dovuto abituare ad ogni tipo di caffè, specialmente a quello ottenuto con il metodo della percolazione, cioè per caduta, una preparazione sconosciuta in Italia, (se non, tangenzialmente, nella caffettiera napoletana), un caffè che nella nostra penisola apparirebbe ad un italiano come una brodaglia. Nell’ultima decade, ho dovuto assistere agli eroici e fallimentari tentativi di innumerevoli franchises di imitare ciò che si fa in Italia, con risultati tra il povero e il patetico, per non dire velenosi ed imbevibili. Siamo d’accordo, le copie sono un complimento e le ibridazioni sono inevitabili! Ma solo ripartendo da zero, come i giapponesi hanno fatto da un pianoforte Steinway o da un Bechstein si può arrivare alla brillantezza di uno Yamaha C3, il cui suono è notoriamente più adatto al jazz. Ma qui vi parlo della sommaria praticità degli americani, non del meticoloso decostruzionismo dei maghi dell’estremo Oriente, che oggi producono automobili che sconoscono il meccanico. La mia pluriennale sperimentazione con multipli metodi di preparazione, tutti rivolti all’ottenimento di una tazza ideale, benché culturalmente ibrida, mi dà oggi l’autorità di parlarne con competenza. Del resto, a casa ho ben sei sistemi e metodi diversi per produrlo, inclusa la famosa Miele ad incasso, una macchina da bar e l’immancabile arsenale di caffettiere Moka Express.

Cominciamo dal fatto che, le cose fatte “all’italiana” sono solo apparentemente semplici. Dietro a un vero caffè espresso si nasconde un lungo lavoro di perfezionamento, dall’invenzione della macchina a pressione di vapore; alla caffettiera Moka Bialetti di Luigi Di Ponti del 1933; dalla ricerca della miscela ideale all’eliminazione di elementi superflui ed estranei. Simmetricamente, le cose fatte alla maniera americana sono ingannevolmente complesse. Sono aspetti particolarmente evidenti a chiunque immigri negli Stati Uniti. In America, la disponibilità di mille scelte per la personalizzazione di ogni bevanda – una autentica fissazione americana – difficilmente riesce a migliorare complessità dell’oggetto a cui viene applicata. Anzi, ne maschera spesso le caratteristiche essenziali. È una mia tesi che mi rammenta di un’affermazione di Oscar Wilde: “I piaceri semplici sono l’ultimo rifugio della complessità”. Ma tralasciamo per un momento le ragioni per le quali dietro un’apparente semplicità può esserci un sorprendente livello di complessità, e viceversa. E rimandiamo a dopo anche il perché la varietà e l’assortimento manchino spesso di definire l’oggetto; ambedue, questioni che sconfinano nella filosofia. E concentriamoci per ora sulla pratica, anch’essa rivelatrice di come e perché questa bevanda sia uno degli elementi ideali per descrivere le differenze del rituale per sé; partendo dal fatto che se in Italia il caffè è un breve episodio, ma con i connotati di una cerimonia, in America è quasi un costante compagno di vita ad ogni ora del giorno e, per gli insonni e per chi lavora, anche della notte.
Parto da un dato scontato: l’espresso ristretto italiano è l’essenza suprema del caffè, la sua vetta interpretativa assoluta, tale da far scivolare impietosamente più in basso qualsiasi altro genere di preparazione. Non lo dico da patriota, quanto da intenditore. Questo è possibile grazie al metodo di estrazione degli elementi più gradevoli e aromatici del chicco di caffè: gli olii essenziali. E questo, pur precisando che anche quando si tratta di caffè, i gusti degli italiani prevedono e ammettono diverse varianti della stessa bevanda; è un po’ quello che succede con gli arrangiamenti di uno stesso pezzo musicale. È noto, infatti, che partendo dal basilare espresso, se ne possono declinare una quantità di versioni, come il macchiato o il caffè corretto. Persino chi non può bere caffeina viene ammesso nel circolo dei degustatori. Al bar, la richiesta del decaffeinato diventa una pubblica ammissione di avanzata età, ipertensione o problemi cardiaci, senza che però nessuno si permetta di commentare o tanto meno di criticare. Al contrario, al richiedente di un decaffeinato viene offerta una silenziosa e benevola forma di solidarietà, proprio in riconoscimento del suo desiderio di mantenere comunque vivo questo sacro rituale nazionale, anche a discapito di una condizione cardiaca non perfetta. Al bar, insomma, l’Italia diventa per davvero una nazione unita. In America, invece, il caffè è un’esperienza strettamente individuale che difficilmente sfocia in un senso di collettivismo. È come fare il pieno dell’automobile: una necessità, non di certo un rito.