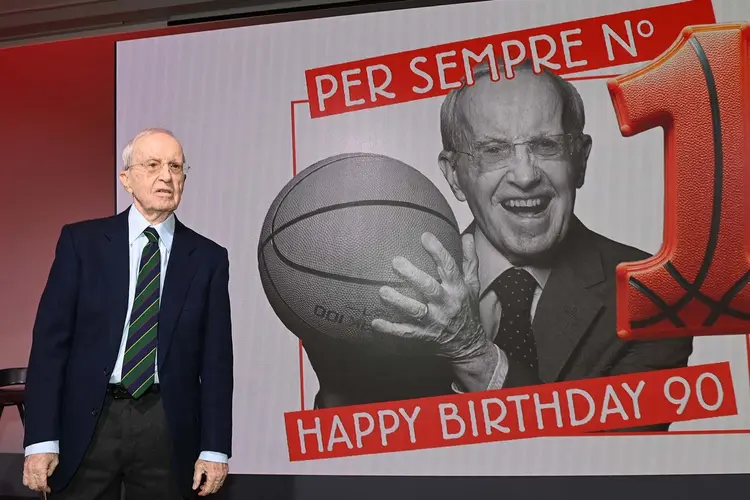Il Giubileo dei Giovani, che si è recentemente concluso, ha rappresentato un momento di intensa spiritualità e riflessione per la Chiesa e per i suoi membri più giovani. Questo evento, voluto da Papa Francesco, ha offerto un’opportunità unica di incontro, confronto e approfondimento in un contesto di comunità globale.
Uno degli aspetti più significativi di questo Giubileo è sicuramente stata l’enfasi sulla voce dei giovani all’interno della Chiesa. Papa Francesco ha spesso sottolineato l’importanza di ascoltare i giovani, non solo come destinatari del messaggio cristiano, ma come attori protagonisti nella costruzione del futuro della Chiesa. “Non allarmiamoci se ci scopriamo interiormente assetati, inquieti, incompleti, desiderosi di senso e di futuro. Non siamo malati, siamo vivi!”, aveva detto Papa Francesco nell’agosto del 2023, messaggio oggi ripreso da Papa Leone XIV, aggiungendo di non colmare la propria sete con “inefficaci surrogati”.
Ne abbiamo parlato con Vincenzo De Lucia, Interlocutore Referente della Pontificia Accademia di Teologia, che abbiamo incontrato durante la sua trasferta negli Stati Uniti, preparatoria al Minority Forum delle Nazioni Unite.
Innanzitutto, vorremmo sapere qualcosa in più sulla Pontificia Accademia di Teologia.
Nella Lettera Enciclica Laudato sì, nr. 114, Papa Francesco impegna la Teologia a vivere una svolta decisiva, un cambio di paradigma, una «coraggiosa rivoluzione culturale», affinché si rafforzi la consapevolezza d’essere una teologia fondamentalmente contestuale. Di fronte a questa rinnovata missione, la Pontificia Accademia di Teologia, presieduta da S.E. Mons. Antonio Staglianò, è chiamata a sviluppare il dialogo transdisciplinare con gli altri saperi scientifici, filosofici, umanistici e artistici, con credenti e non credenti, con uomini e donne di differenti confessioni cristiane e differenti religioni.
Quali sono le sue riflessioni in relazione alle difficoltà giovanili?
La mia prima considerazione va alla fragilità dell’identità giovanile. Difatti, una delle sfide più significative che il mondo contemporaneo presenta è la fragilità dei giovani nella ricerca di un’identità stabile. La frammentazione dei punti di riferimento, dei valori e delle prospettive segna profondamente la loro vita quotidiana. Inoltre, osserviamo una tendenza spontanea a resistere a qualsiasi proposta che richieda una continuità di dedizione. Questo fenomeno sembra riflettere una paura intrinseca: quella di investire la propria esistenza in una causa che vada al di là dell’immediato e del superficiale. Ed a ciò si aggiunge, sempre più frequentemente, la mancanza di capacità riflessiva. Questo indebolimento del pensiero si estende a desideri, valori, giudizi, decisioni, impegni e obiettivi. La persona diventa così meno convinta dell’importanza dei valori morali rispetto alle proprie esigenze di gratificazione, affermazione e autonomia.
Quali sono le sue riflessioni sui giovani, in relazione ai concetti di spiritualità e perdono?
Sono concetti molto ampi, che richiedono svariati approfondimenti. Ciò che posso sintetizzare è che viviamo in una cultura caratterizzata da una crescente difficoltà nella comprensione della spiritualità e del perdono. I giovani, in particolare, si trovano a fronteggiare domande provocatorie che interrogano la loro stessa esistenza. In che modo è possibile parlare della dimensione del perdono in un contesto che esalta il consumo e il possesso materiale? E, prendendo in considerazione alcune sfide fondamentali in merito alla spiritualità, come si può promuovere l’autentica fraternità e la generosità in una società che celebra l’individualismo e l’autorealizzazione narcisistica? In questo panorama, la questione del perdono assume una dimensione cruciale. Il perdono richiede un atto di volontà e una riflessione profonda, ma in una cultura che celebra l’immediato e il superficiale, rischia di essere relegato a un concetto astratto, distante dalla vita quotidiana.
La teologia può andare incontro a quanto descritto?
La teologia può offrire una visione della spiritualità e del perdono che va oltre la mera assenza di rancore: il perdono è un atto di grazia, che implica una riconciliazione con l’Essere Supremo, con gli altri e con se stessi. È un cammino di liberazione, che non solo cura le ferite relazionali, ma invita i giovani a costruire una cultura della fraternità e della solidarietà. Proporre il perdono in questo contesto significa affrontare le sfide del mondo contemporaneo con una visione che valorizza l’impegno, la responsabilità e la capacità di costruire legami autentici. È un invito a guardare oltre i propri bisogni immediati, verso un orizzonte di significato più profondo. In questo contesto, emerge una forte sete di senso e di significato, un desiderio di scoprire motivi per vivere e orientare le proprie scelte. È evidente che il cammino identitario deve partire da un singolo “frammento”, conducendo i giovani verso la scoperta di un tutto più ampio, prima che siano costretti a vivere in uno stato di paralisi spirituale. Se i giovani sono il futuro, occorre fornire gli strumenti necessari per crearlo.
E come andrebbe interpretato l’annoso dibattito giovanile tra fede e scienza?
Su questo mi affido a quanto esposto da un più autorevole interlocutore, don Maurizio Bloise, illustre membro della Pontificia Accademia di Teologia:
“Possono sembrare due macro aree o macro tematiche distanti. E andrebbero sempre affrontate senza cadere in inutili speculazioni: gli ultimi anni sono stati tra i più sereni su questo dibattito, tant’è vero che proprio in questi giorni stiamo ripensando, a livello teologico, alla Fides et Ratio, l’enciclica di Papa Giovanni Paolo II pubblicata nel 1998, che esplora il rapporto tra fede e ragione. Ratzinger, allora Cardinale prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, partecipò alla presentazione dell’enciclica insieme ad altri, sottolineandone l’importanza. L’enciclica afferma che fede e ragione sono come due ali che permettono all’uomo di elevarsi alla contemplazione della verità. Un testo che parla del confrontarsi e del dialogare con tutte le scienze e le realtà scientifiche.
La teologia o i teologi non sono un deposito di fede, di contenuti. Certo, hanno magari un’attitudine un po’ diversa, ma non certo “migliore” di quella di altri. Pensiamo ad esempio alla principale tematica degli ultimi tempi: tutti corrono dietro all’intelligenza artificiale. Un inciso: penso che in Italia, su questi argomenti, si scriva tantissimo, si legga pochissimo e se ne parli malissimo. Comunque, sull’intelligenza artificiale si muovono delle osservazioni o anche delle preoccupazioni. A mio avviso il problema è quando il dialogo, in senso lato, diventa a senso unico. E affidarsi a senso unico a qualcosa, in particolare in ambito scientifico, può divenire quantomeno fuorviante. L’intelligenza artificiale non è intelligente quanto l’essere umano. Avrà senz’altro tutte quelle capacità. Ma chi ha creato questo strumento è comunque l’Uomo. Forse l’elemento più importante nell’affrontare tale argomentazione è il fatto di non affidarsi ad improvvisati, bensì a coloro che studiano il fenomeno con attenzione, passione e professionalità.”
Un’ultima domanda: con quale spirito la Pontificia Accademia di Teologia può dare un apporto positivo ai giovani?
Per questa risposta mi affido al più illustre testimone di tale spirito, il Presidente della Pontificia Accademia di Teologia S.E. Mons. Antonio Staglianò, che diede questa testimonianza in occasione dell’inaugurazione della nuova sede:
“Vi accolgo con un verso di un poeta, Hölderlin: “Chi ha pensato il più profondo, ama il più vivo, il più puro.” E’ un passaggio che stringe fortemente il pensiero con il vissuto, con la vita. Poiché quando un pensiero è autentico, nasce dalla vita, nasce dal vissuto, e termina nella vita.
Papa Francesco con una Lettera Apostolica in forma di Motu proprio – Ad Theologiam promovendam, con la quale approva i nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia, chiede un allargamento sapienziale dei confini della ragione teologica, come già proposto da Benedetto XVI a tutti gli altri saperi critici. Tale Lettera Apostolica è veramente una fonte di grande ricchezza per originare un pensiero, anche ben organizzato, e potremmo dire in questo versante anche scientifico, una sorta di progetto teologico, sapienziale e culturale che davvero ci aiuti ad aiutare il vissuto della gente, la vita di fede della gente, la società cristiana dentro società pluralistiche, multi religiose, multirazziali. Ci aiuta anche ad immaginare una visione dell’umano che risulti resiliente rispetto a tante barbarie dal volto umano che la “società dell’ipermercato” ci sta mettendo davanti, e che alletta così tanto i giovani di oggi. Milioni di “followers” vanno appresso ad estetismi antropologici che sono assolutamente vuoto totale. Quindi la vera novità della Pontificia Accademia di Teologia è l’immaginazione della teologia sapienziale, teologia che sa di carne, di popolo. Attraverso ciò entriamo in questa incarnazione, un pensatoio orientato alla vita delle persone.
“Voi siete il segno che un mondo diverso è possibile: un mondo di fraternità e amicizia, dove i conflitti non si risolvono con le armi, ma con il dialogo”, ha sottolineato Leone XIV ribadendo dunque che la pace è possibile, laddove vi sia la volontà di raggiungerla e mantenerla.