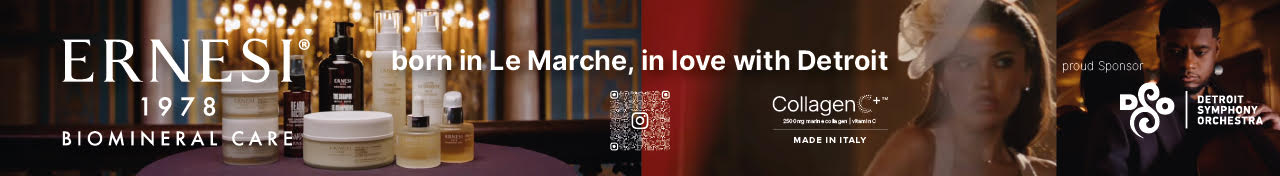Tra le luci di Times Square e il flusso continuo di turisti, è comparsa un’idea che ha origine dalla Firenze più antica. Da giugno, un piccolo chiosco richiama le buchette del vino, quelle finestrelle incastonate nei palazzi rinascimentali che in Toscana consentivano di vendere direttamente al passante un bicchiere o una bottiglia. Una reinterpretazione newyorkese capace di trasformare un frammento di storia locale in un oggetto globale di curiosità.
L’iniziativa porta la firma di Jack Logue e Chris Miller, rispettivamente chef e imprenditore, che hanno scelto la 7th Avenue, tra la 43esima e la 44esima strada, come palcoscenico per la loro versione americana della buchetta. L’offerta va oltre il vino e comprende piatti veloci e dolci, in una formula che adatta la tradizione fiorentina ai ritmi frenetici della metropoli. La scelta del nome, “Buchette del Vino”, non lascia poi spazio a equivoci.
Il successo dell’apertura si misura anche nella rapidità con cui è diventata un contenuto virale. Su Instagram, video e fotografie mostrano la finestra newyorkese circondata da cartelloni pubblicitari e grattacieli. L’immediatezza visiva delle buchette, nate per la praticità del commercio quotidiano, oggi diventa un punto di forza in un mondo in cui la riconoscibilità è un valore economico.

A Firenze, queste aperture nei muri risalgono al XVI secolo, quando le famiglie nobili che producevano vino le utilizzavano per vendere direttamente senza intermediari. In città se ne contano ancora circa 170, ma solo poche sono funzionanti. Negli ultimi anni hanno conosciuto una rinascita, complici iniziative di valorizzazione e l’inaspettato ruolo avuto durante la pandemia: con il distanziamento sociale, quelle finestrelle hanno permesso di servire bicchieri e piatti senza contatto diretto.
La loro trasposizione a New York rappresenta un ulteriore passo nel processo di trasformazione delle buchette in simbolo culturale. Da elemento architettonico funzionale sono diventate attrazione turistica, poi fenomeno social e adesso, persino a migliaia di chilometri, testimonianza di come una tradizione locale possa adattarsi a linguaggi globali. L’operazione di Logue e Miller conferma la tendenza all’esportazione di dettagli identitari italiani che, nel tempo, si affermano come icone della convivialità mediterranea anche in contesti molto lontani dal loro luogo d’origine.