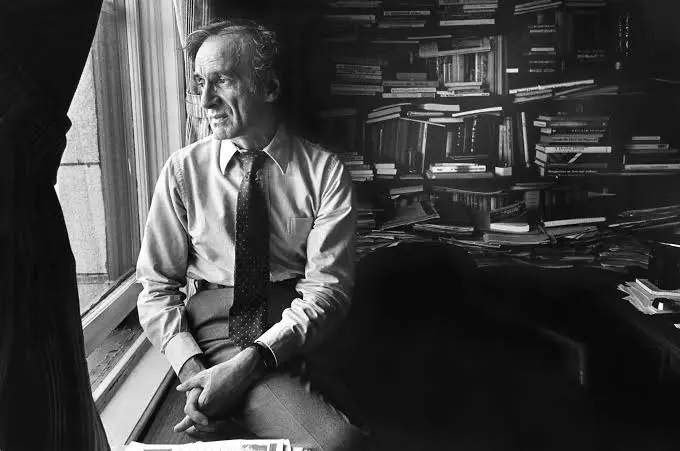Il popolo ebraico costituisce lo 0,2% della popolazione mondiale, Sono appena 16 milioni di persone, su 8 miliardi che popolano la terra. Eppure, fra poco più di 1000 premi Nobel che, dal 1901, sono stati assegnati, in tutte le discipline e campi del sapere, ben il 22% dei premiati sono di origine ebraica: 230 Nobel. In base a una proporzione pura avrebbero dovuto essere solo 2. A che cosa è dovuto questo “squilibrio”? Basterebbero questa premessa, crudamente quantitativa, e gli interrogativi che essa suscita, a giustificare pienamente l’impegno profuso da Paolo Agnoli in questo suo volume sintetico, acuto ed essenziale, pubblicato da Albatros col titolo “Gli ebrei e la cultura”.
Ma è opportuno incalzare ancora coi numeri: sono ebrei il 38% di quanti hanno riscosso la “Medal of Science”, il 33% di quelli che hanno ottenuto il “Wolf Prize”, il 24% di quanti sono stati insigniti del “Kyoto Prize”. Non vi riporto i dati di quanti riconoscimenti hanno ottenuto gli ebrei in campo letterario, musicale, filosofico, psicologico e vi risparmio l’elenco dei premi Oscar assegnati a Hollywood ad attori, sceneggiatori, registi … di origine ebraica.
Dietro alla scoperta delle più importanti medicine, penso solo ai vaccini, (ma anche agli antibiotici) c’è come minimo lo zampino di uno scienziato ebreo. E la rivoluzione informatica, da Budapest a Ivrea, ha avuto fra i pionieri studiosi e imprenditori di origine ebraica, che hanno transitato il mondo nell’era digitale, dalla Silicon Valley a Tel Aviv. E che dire del progetto Manhattan, grazie al quale si è scritta la parola fine di un conflitto che aveva mietuto 60 milioni di vittime? Volutamente sto evitando di fare nomi, anche se Paolo Agnoli ne cita centinaia e, vi assicuro, sono meno di quelli che mancano all’appello, ma se avesse voluto citarli tutti, le pagine del suo intrigante libro non sarebbero bastate.
Acclarata questa straordinaria propensione fra gli ebrei in rapporto alla scienza, all’arte, alla creatività, la domanda ritorna in modo prepotente: a cosa è dovuta? La risposta, come è ovvio, ha sì un carattere multidimensionale, ma, come vedremo, ha anche un “centro”. Confesso che io stesso mi sono posto in passato il medesimo interrogativo, arrivando a conclusioni perlopiù convergenti col punto di vista di Agnoli. Vediamo.
Nel corso della storia abbiamo assistito alla parabola di grandi civiltà, e fondamentali centri di evoluzione culturale, che dopo fasi eclatanti di splendore e sviluppo, si sono poi avviate sulla mesta china della decadenza, basti pensare alla fucina della filosofia e dell’idea democratica: la Grecia. Ad oggi si contano solo 2 premi Nobel Greci. In effetti il declino delle civiltà si associa alla debacle militare ed alla conseguente colonizzazione del “territorio”. È stato così, in fondo, per tutte le più grandi esperienze “imperiali” della storia. Ma è stato così anche per gli ebrei, che in seguito alla sconfitta subita nel 70 d.c. da parte delle legioni di Tito, si videro costretti in buona parte alla diaspora, (solo una porzione di essi non si è mai spostata da Gerusalemme e da quell’area). Quindi come hanno fatto a conservare e trasmettere l’identità, la memoria culturale, la tradizione?
La risposta è fondamentalmente racchiusa nel concetto che li identifica: “Il popolo del libro”: Laddove altre popolazioni, perduto l’insediamento geografico, hanno smarrito con esso, progressivamente, anche la memoria culturale, l’identità, la radice, gli ebrei l’hanno conservata in pieno, perché il loro territorio, per migliaia di anni, non è stato semplicemente “fisico”, ma intellettuale. Per secoli si è stati ebrei non perché nati a Gerusalemme, in Giudea o Samaria (che oggi si chiamano Cisgiordania, Palestina ecc.) ma perché conoscitori, lettori e studiosi della Torah. Se non leggi la bibbia non sei ebreo. Semplice. Questo anche in epoche e aree dove il 90% di tutte le altre popolazioni era analfabeta, che è forse uno dei motivi di invidia a fondamento dell’antisemitismo. La quale si combina con la storica accusa di deicidio, peraltro riferita a un nobile filosofo, sublime predicatore della libertà e dell’eguaglianza, un giovane ebreo circonciso di nome Gesù.
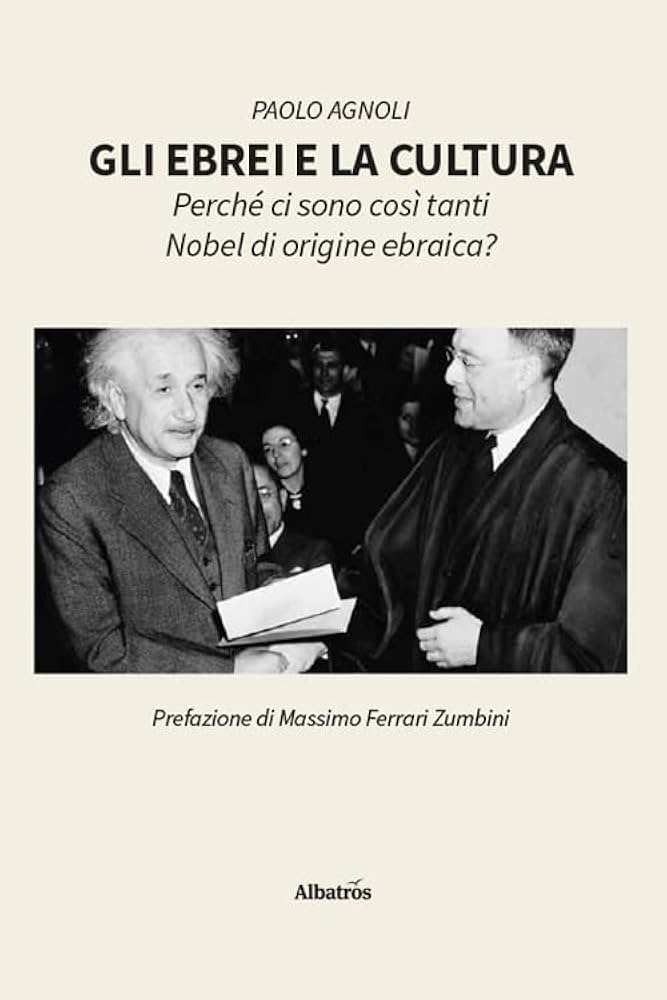
Anche la sua mamma era ebrea. E da bambino la mamma ebrea ti “impone” di studiare il Talmud e rispondere correttamente alle sollecitazioni del rabbino, a dibattere, insieme agli altri ragazzini il “significato”, ad addestrarti nelle trame del pensiero “razionale” e a sviluppare il senso “critico” e ad affinare gli strumenti di interpretazione. Questo accadeva anche fra gli ebrei esuli, fuggiaschi, perseguitati, costretti a imparare lingue, usi e costumi delle “nazioni” che, “temporaneamente” li ospitavano … fino al prossimo Pogrom.
Eppure, l’ebreo errante aveva una sua patria, che lo avrebbe accudito e accompagnato sempre e ovunque: il libro e lo sguardo “esigente” della madre. Insomma, gli ebrei non sono un relitto culturale, inspiegabilmente sopravvissuto, come pensava Arnold Toymbee, ma sono al contrario la prova di come può insorgere e funzionare un metodo alternativo, uno strumento peculiare, una strategia originale di sopravvivenza, quando tutte le condizioni sono avverse.
La scoperta dell’agricoltura, si sa, è stata la matrice di tutta la civiltà prodotta da Sapiens, ma è ben noto che agli ebrei era proibito possedere la terra, in epoche nelle quali il 95% dell’economia era agricola. Una limitazione tremenda, che avrebbe annichilito le prospettive di qualunque gruppo sociale. Ma gli ebrei avevano il libro, lo studio, l’arguzia. Poco male, sarebbero diventati inventori, filosofi, medici, e avrebbero curato i gentili … fino al successivo pogrom. Avrebbero frequentato arti, mestieri, sarebbero diventati sarti, ebanisti, pizzicagnoli, usurai…banchieri, occupandosi della più grande scoperta filosofica della civiltà umana, la misura astratta del valore: la moneta. Trasformando, così, in nuove opportunità i divieti all’esercizio delle attività economiche che subivano di volta in volta.
Mentre i ghetti funzionavano come network ineluttabili di socievolezza e comunità, fertilizzando, per questa via Simmeliana, fiorenti terreni di coltura della creatività. Paolo Agnoli contesta, giustamente, l’ipotesi di una radice “genetica” del virtuosismo giudaico, anche perché gli ebrei si sono ibridati, praticamente, con tutte le etnie del pianeta, e ci sono ebrei gialli, bianchi, neri, insomma appartenenti a tutte le varietà biologiche di cui è composta la nostra specie. Ma fra i fattori concomitanti che possiamo annoverare riguardo alle ragioni del loro primato “intellettuale”, forse non è da escludere il meccanismo crudele di selezione culturale, subito attraverso le infinite persecuzioni, nelle quali a sopravvivere, probabilmente, sono stati i più “capaci” sul piano psicologico, tecnico, intellettuale.
Del resto è Primo Levi ad aver dimostrato come, persino nei campi di sterminio, ad avere maggiori probabilità di restare in vita non erano i più forti fisicamente, ma i più dotati, perché erano bravi a fare qualcosa: contabili, idraulici, meccanici, architetti, muratori, musicisti finanche. Questi avevano maggiori speranze di sopravvivenza di quelli che non possedevano particolari doti o competenze e quindi per le belve naziste non avevano alcuna possibile utilità. Insomma, l’ammirazione malcelata per le capacità alfabetiche, l’invidia per le qualità letterarie, le doti linguistiche, la cultura degli ebrei, generando la barbarie storica dei pogrom esercitata per migliaia di anni, fino al culmine storico della Shoa, possono essere fra i fattori che hanno costituito l’ambiente darwiniano di sopravvivenza dell’identità e della tradizione ebraica.
Un discorso a parte merita la “cucina” Kosher, gustosissima peraltro, ma che nella sua realizzazione “ortodossa” conserva alcuni divieti, criteri, abbastanza singolari e bizzarri, inspiegabili, se non sulla base di indizi disseminati fra le righe del “Libro”. Confesso che lo stesso Marvin Harris, il quale ha fornito spiegazioni abbastanza “razionali” intorno a tutte le tradizioni alimentari del pianeta, quando si è occupato della cucina ebraica non mi ha convinto e secondo me si è pure un po’ incartato.
Paolo Agnoli non ha affrontato il tema nella sua bella ed efficace dissertazione, eppure la tecnica e la tradizione alimentare sono un pezzo decisivo della “cultura”, questo vale per tutte le civiltà, etnie, nazioni. E la cucina ebraica ne solleva di interrogativi: perché non combinare certi umori, a partire dal latte, con altre secrezioni animali? E perché il divieto assoluto per i frutti di mare, per crostacei, molluschi, in base al precetto secondo il quale i pesci devono avere sia pinne, sia squame? Mi fermo qua, evitando di citare diverse altre norme strane e singolari. Qui la “razionalità”, di cui parla diffusamente Paolo Agnoli, quale matrice della spinta intellettuale presente nella visione ebraica sembra tentennare.
Ma forse tutto dipende, paradossalmente, ancora da essa. Il fatto è che nell’immaginario ebraico il paradiso non c’è, l’autore lo dichiara a chiare lettere, la vita è questa terrena, ed è attraversata dal caos. Per “cercare” la felicità, qui ed ora, vi è la necessità di dare ordine al tutto, si tratta di un bisogno insopprimibile, abbiamo l’esigenza di darci delle regole, sarebbe meglio dire una regolata. A prescindere. E può essere solo la Torah a indicarci la via. Spesso dobbiamo obbedirle modo didascalico, ma non sempre: il libro è pieno di nascondigli e trabbochetti, talvolta anche mascherati da un raffinato umorismo (altra caratteristica tipicamente ebraica). Insomma, bisogna leggere e affinare il lavoro dell’ermeneutica, per comprendere le allegorie, i messaggi, le metafore esplicite e i segni segreti, di cui è disseminato il testo, come un codice cifrato, di cui bisogna carpire i misteri semiotici, studiando all’infinito. Forse è proprio questo studio, combinazione cabalistica fra scienza e immaginario, storia e mito, vita e destino, fisica e metafisica, la cucina nella quale lievita quella creatività, quello spirito di intraprendenza e inventiva che gli ebrei hanno regalato al mondo.