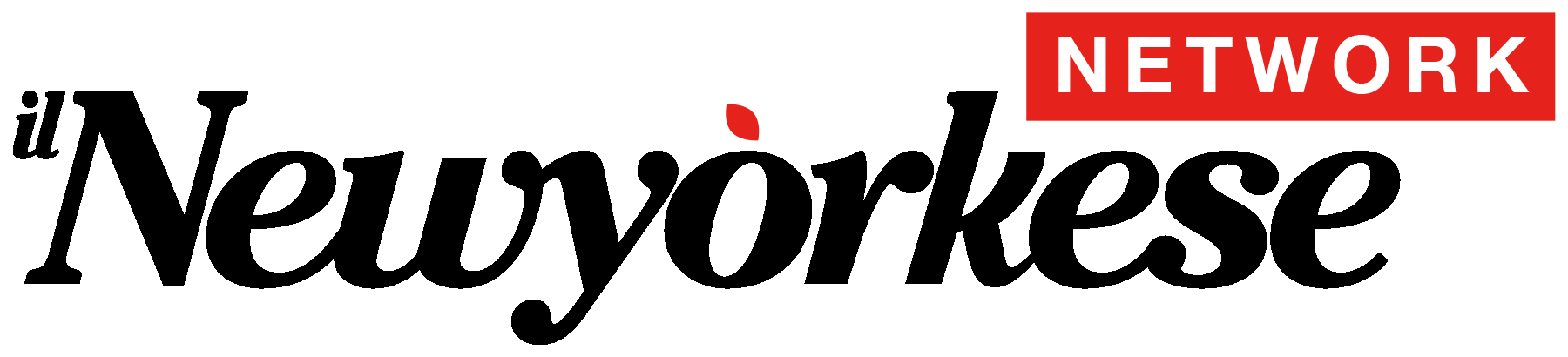A. L. è una giovane professionista italiana che vive e lavora a New York. Prima di arrivare negli Stati Uniti, ha affrontato un’esperienza personale determinante, che l’ha costretta a confrontarsi con le proprie certezze e a ridefinire la propria traiettoria di vita. In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, abbiamo scelto di ascoltare la sua testimonianza: una storia di autodeterminazione, nata da una decisione difficile e culminata in un nuovo inizio.
Dieci anni fa hai vissuto un’esperienza molto personale che ha segnato la tua vita. Puoi raccontarci un po’ di quel periodo?
All’epoca ero molto diversa da oggi. Avevo poco più di vent’anni, ancora intrappolata tra le insicurezze dell’adolescenza e quella fame confusa di libertà che ti spinge a voler trasgredire nel tentativo di cercare te stessa, ma nei posti sbagliati. È stato così che sono entrata, senza davvero accorgermene, in una relazione tossica. All’inizio sembrava tutto perfetto. Quello che oggi definirei love-bombing, allora lo interpretavo come genuino interesse, protezione, intensità. Poi, lentamente, sono arrivati i primi segnali: piccole manipolazioni, sensi di colpa costruiti ad arte, quel “mi manchi” recitato ogni volta che uscivo con le mie amiche, come se la mia indipendenza fosse un torto personale. Era l’inizio di un addomesticamento sottile che ben presto è degenerato in gelosia ossessiva, oggetti rotti, e poi negli scatti di aggressività verso di me. Sapevo che non era normale, ma vivevo in una nebbia emotiva e non sapevo come venirne fuori. Quella dinamica stava consumando tutte le mie energie, ma non te ne accorgi subito: la violenza, soprattutto quella emotiva, non arriva come un colpo secco, ma come un lento spostamento del baricentro. Ti ritrovi a vivere una realtà che non assomiglia più a te, ma continui a giustificarla. Dicevo “basta” tante volte, ma ogni “no” veniva risucchiato dal ciclo del perdono e del suo pentimento momentaneo. Così sono passati cinque anni.
Il “no” definitivo è arrivato quando ho capito che stavo davvero perdendo me stessa. Eppure il destino aveva un ultimo colpo in serbo: poco più di un mese dopo quella rottura ho scoperto di essere incinta. Lui l’ha usato come un’arma: “Così non ti libererai mai di me”, mi disse durante una delle ultime litigate al telefono. Io gli risposi: “Invece io mi libero di te, eccome.” Quella frase, credo, è stata il mio primo vero atto di autodeterminazione. La notizia della gravidanza è stata inevitabilmente la sveglia che non potevo più ignorare.
Guardando indietro, quali emozioni ricordi più vividamente? Ci sono stati momenti di paura, sollievo o conflitto che ti hanno segnato particolarmente?
Verrebbe da immaginare questi momenti con una reazione esplosiva, invece io rimasi impassibile. Fredda, quasi insensibile. Ricordo la lucidità con cui ho chiamato la mia migliore amica dicendole: “So già cosa devo fare. Abortisco. Sto andando dalla ginecologa.” Le ho chiesto solo di raggiungermi. Nessun tremore. Nessun dubbio. Era come se non stesse succedendo a me. “Dissociazione da shock”, così lo aveva definito la psicologa. È una risposta neurobiologica di emergenza che si attiva durante eventi traumatici: il sistema nervoso entra in modalità di protezione e “stacca” temporaneamente l’accesso alle emozioni, per permettere di funzionare, decidere o semplicemente sopravvivere. Una fase caratterizzata da iper-lucidità. Ma non significava che non stessi provando niente: ero semplicemente anestetizzata. Il conto, infatti, è arrivato poche settimane dopo.
Quando sono entrata in ospedale per l’interruzione di gravidanza farmacologica, ero da sola, chiusa nella stanza, senza la possibilità di avere qualcuno accanto. L’infermiera è entrata e, porgendomi la pillola, ha detto: “Questa serve ad arrestare il battito cardiaco dell’embrione.” Parole che mi hanno trafitta. Tutto ciò che avevo tenuto sotto ghiaccio è tornato in superficie di colpo: vergogna, paura, senso di colpa. Mi sono sentita sporca, come se stessi facendo qualcosa di immorale e profondamente sbagliato, come se non avessi alcun diritto di decidere su una vita che ancora non vedevo, ma che sapevo esistere.
Così ho chiamato mio cugino, che in quel periodo mi stava molto vicino, e piangendo a singhiozzi gli ho detto che ci avevo ripensato e che avrei tenuto il bambino. Lui mi ha detto una frase che non dimenticherò mai: “Va bene, la vita è tua. Sai che se scegli un DVD vivrai un certo tipo di vita, se scegli l’altro DVD ne vivrai un’altra. Ma sappi cosa stai scegliendo.” Quell’immagine, così semplice e concreta, mi ha rimesso a terra. Mi ha obbligata a guardare la realtà senza filtri: non ero pronta. E non avrei voluto crescere un bambino con quel ricordo e con l’ombra di quella persona.
Ho scelto di andare fino in fondo. Sono tornata in ospedale 48 ore dopo per completare il processo. Ricordo un senso di sfinimento e smarrimento, come se fossi stata svuotata da dentro. Ma quello “svuotamento” era solo una coperta sopra emozioni molto più profonde: una tristezza densa e una rabbia silente, ma non distruttiva, e che non avevo mai permesso a me stessa di sentire, perché cresciamo credendo che quelle emozioni siano “negative” e da mettere a tacere. In realtà non sono nemiche da contenere, ma bussole da imparare a direzionare. La tristezza mi mostrava quanto mi fossi allontanata da me stessa. La rabbia mi diceva che era ora di smettere di rimpicciolirmi. Per la prima volta non l’ho rivolta verso l’esterno, ma verso di me — non per punirmi, ma per svegliarmi: “Basta sentirmi vittima. Basta dire è ‘colpa sua’. Tu hai permesso tutto questo. E adesso hai il potere di non permetterlo più.” È stato un ribaltamento interno. La tristezza e la rabbia si sono intrecciate diventando un motore nuovo, che non mi spingeva più a resistere, ma a uscire. Ma quella scelta, pur dolorosa, è stata il mio primo vero atto di libertà.
Qual è stato il ruolo delle persone intorno a te in quell’esperienza? Hai trovato supporto o ti sei sentita giudicata?
Sono stata molto fortunata per quanto riguarda le persone care intorno a me, nessuna mi ha giudicata. Anzi, ho trovato un supporto che non davo per scontato. La mia migliore amica è stata la prima a cui l’ho detto, e non ha avuto un attimo di esitazione: è uscita prima dal lavoro e mi ha raggiunta dalla ginecologa. Le mie sorelle mi supportavano. Mia mamma — che avevo paura di deludere — mi ha detto che al mio posto avrebbe fatto la stessa cosa e che lei era lì per me. Quella frase mi ha tolto un peso enorme. Ma la presenza più costante è stata quella di mio cugino. È stato un vero pilastro in quel periodo. Passava ore al telefono con me, veniva spesso da me dopo il lavoro, e se ne andava solo quando era sicuro che mi sentissi più tranquilla. La sua frase, quella del DVD, la porto ancora con me quando devo prendere decisioni importanti. Mi ricorda che qualunque strada io decida di imboccare… devo essere consapevole e pronta ad accettare le conseguenze.
L’esperienza medica invece e’ stata un po’ diversa. La mia ginecologa — la prima persona a cui mi sono rivolta — era obiettrice di coscienza. Non mi ha accompagnata nel percorso, e mi sono ritrovata a dover cercare qualcun altro tramite conoscenze, perdendo giorni che in quel momento erano preziosi. Ero alla quinta settimana, e avevo pochissimo tempo per ottenere il via libera medico necessario e procedere con l’interruzione farmacologica: altrimenti avrei dovuto passare al raschiamento, molto più invasivo. In quel momento non avevo dato troppo peso alla sua scelta di non aiutarmi; ero troppo concentrata sul da fare. Ma a posteriori ci ho pensato. Mi ha ferita perché da un medico non cerchi un giudizio: cerchi cura. La missione di un medico dovrebbe essere quella di accompagnare, non alzare barriere; è offrire sostegno nel momento più delicato, non voltarsi dall’altra parte. Quando chi dovrebbe offrire quel supporto decide invece di giudicare le tue scelte personali, si rompe il rapporto di fiducia a livello umano, ma anche nell’idea stessa di ciò che dovrebbe rappresentare quella professione. Aveva in cura anche le mie sorelle e mia madre, ma ovviamente, dopo quella storia, nessuna e’ piu’ tornata. Con una sola mossa si era giocata 4 pazienti.
In che modo quell’esperienza ha influenzato il tuo rapporto con te stessa, con il tuo corpo o con le tue scelte di vita negli anni successivi?
Penso di avere una capacità introspettiva alta. Questo mi ha sempre permesso di elaborare le esperienze con una certa rapidità. Soprattutto perché non aggiro il dolore: lo attraverso. Pago il prezzo emotivo che devo pagare, ma proprio per questo, quando il peggio è passato, riesco ad andare avanti senza voltarmi troppo indietro o rimanere ancorata a energie negative. Questa esperienza è stata un viaggio di consapevolezza in tanti sensi diversi. Ho capito perché per anni avevo portato avanti una relazione che mi stava consumando, quali erano i meccanismi interiori che mi trattenevano, quali paure mi immobilizzavano. Ho riconosciuto le parti vulnerabili di me che meritano protezione, ma anche i miei punti di forza. Ad esempio, so di essere in grado di restare solida nelle situazioni altamente stressanti, persino traumatiche. So prendere decisioni difficili, so ricostruirmi e ricominciare da capo, e non è qualcosa che mi spaventa — anzi. Molte persone hanno paura di lasciare il noto per l’ignoto. Io no. Per me l’idea di ricominciare è quasi eccitante: è un modo per riaffermare che la mia vita può sempre essere riscritta da me.
Infatti, ricordo perfettamente il momento in cui sono uscita dall’ospedale Mangiagalli di Milano: ho chiamato la mia migliore amica e, ridendo e piangendo allo stesso tempo, continuavo a ripetere “è finita, è finita”. Non mi sono mai pentita di quella scelta e non mi sono più voltata indietro. Una settimana dopo ero su un aereo per gli Stati Uniti. Avevo deciso che volevo alzare lo standard e recuperare il tempo perduto. La counselor che mi seguiva al servizio antiviolenza dell’Ospedale Niguarda mi aveva consigliato di prendermi del tempo per elaborare quello che era successo. Ma dopo anni in cui ero rimasta in gabbia, sentivo che restare sarebbe stato un errore, e volevo assecondare la mia fame di liberta’. Rifarei tutto esattamente allo stesso modo, perché quella storia è stata il punto di svolta che mi ha portata fino a New York oggi. Non è stato scrivere un nuovo capitolo, ma cambiare completamente libro. Chissa’ se non l’avessi vissuta, forse oggi non sarei qui…
Se dovessi parlare a qualcuna che sta vivendo una situazione simile oggi, cosa vorresti che sappia?
Innanzitutto, che non sei sola. E poi che quello che stai vivendo non dice nulla del tuo valore. La società spesso interpreta queste situazioni come debolezza, ma non è vero. Restare in relazioni tossiche succede proprio a chi ha una grande capacità di sopportazione, di empatia e resilienza. Qualità che, in un contesto sano, diventano una forza straordinaria. È vero, insieme a questa resistenza convivono delle vulnerabilità, ed è importante riconoscerle senza giudicarle. Ma quella tolleranza così alta non è un difetto: è indice di potenziale. Significa che hai una forza interiore enorme, solo che forse, l’hai diretta verso la direzione sbagliata. E allora il punto diventa: a che livello vuoi vivere? Vuoi continuare a rimpicciolirti per far sentire potente qualcun altro, o vuoi investire quella forza per costruire una vita all’altezza della tua grandezza?
Come pensi che la società italiana/americana (o il contesto culturale in cui eri) veda l’aborto oggi? Credi che la tua esperienza possa contribuire a cambiare percezioni o tabù?
Penso che oggi l’aborto, in Italia e negli Stati Uniti, sia vissuto dentro una grande contraddizione: giuridica, culturale ed emotiva.
Io sono cresciuta in Italia, dove l’aborto è garantito dalla legge 194, ma l’accesso è spesso ostacolato dall’alto tasso di obiezione di coscienza e da un clima culturale ancora molto giudicante. Il messaggio implicito è: “la legge c’è, ma è meglio se non la usi”. E questo alimenta silenzio, solitudine e senso di colpa. Quindi penso che l’ago della bilancia in questo contesto lo dettino le persone accanto.
Negli Stati Uniti, soprattutto dopo la sentenza Dobbs, ho l’impressione che ci sia un grande paradosso. Non c’è una linea nazionale unitaria, ma una mappa a macchie. In alcuni stati l’aborto è quasi totalmente vietato o limitato a poche settimane; in altri è protetto e rafforzato. Qui il tema non è tanto il silenzio, ma la polarizzazione: è guerra di identità, di schieramenti. Sei “pro-life” o “pro-choice”, come se tutta la complessità delle vite reali potesse stare in uno slogan.
In entrambi i contesti, però, sento una cosa in comune: la donna reale sparisce. Si parla di princìpi astratti, leggi, religione, politica… ma molto meno di cosa significhi trovarsi in una relazione violenta, in uno stato di shock, dover decidere in fretta, essere sola in una stanza d’ospedale. Mi sembra che l’aborto sia raccontato o come un mostro morale, o come un gesto quasi neutro, tecnico. Io non mi riconosco in nessuno dei due contesti: ho vissuto questa esperienza come una decisione difficile, ma anche un atto di responsabilità verso me stessa. Ovviamente la mia storia non cambierà le prospettive più ampie. Ma penso che ogni testimonianza onesta sposti di un millimetro lo sguardo.